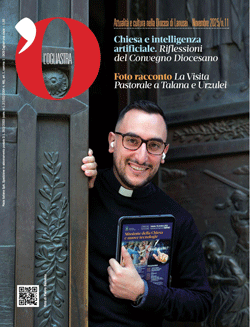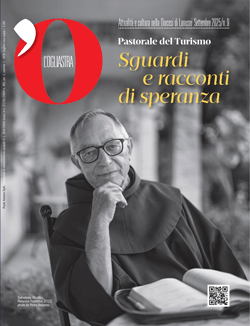Editoriale

Le ragioni del cuore. Giornata Diocesana Giovani a Bari Sardo
di Francesco Orrù.
«Ci sono ragioni che il cuore non capisce e sentimenti che la ragione non comprende; occorre mettere insieme cuore e ragione perché risaltino insieme nella nostra vita».
Con queste parole il vescovo Antonello ha voluto concludere il dialogo con i giovani, momento centrale della giornata diocesana tenutasi a Bari Sardo lo scorso 23 novembre, solennità di Cristo Re, in comunione con tutte le diocesi del mondo che dedicano questa ricorrenza agli incontri diocesani dei giovani.
Momenti di incontro, di preghiera, di riflessione e di amicizia, mani che si sono strette con gioia nella recita del Padre Nostro e che si sono incontrate di nuovo tra musica e balli.
Tanti i ragazzi provenienti dalle comunità della nostra Diocesi, invitati a riflettere sul tema che li accompagnerà durante tutti gli incontri di quest’anno pastorale: le relazioni. Mai come oggi siamo chiamati ad abbandonare il folle narcisismo della nostra società per ritrovare il baricentro al di fuori di noi stessi, dove lo ha posto Cristo: a metà strada tra me e il prossimo. Trovare questa misura non è certo semplice, e le tante domande in merito poste da ragazzi e ragazze lo hanno dimostrato. La risposta non può essere che il Comandamento Nuovo (Mt. 22, 34-40), l’amore totale che prende tre direzioni: Dio, il prossimo e me stesso.
Il diacono Don Antonio Carta, delegato per la Pastorale Giovanile, lo ha descritto nella sua catechesi come «un’indicazione verso la vera felicità, un percorso che ci guida nelle relazioni della vita. Come Dio ci ama totalmente anche quando non ci sentiamo abbastanza, così siamo chiamati ad amare noi stessi come sue creature e a vedere nelle relazioni con gli altri le stelle che ci guidano quando il cielo della vita sembra oscurarsi».
Un amore che da Dio deve riflettersi su di noi se vuole illuminare anche il nostro prossimo, «siate positivi, stimatevi e amate con rispetto: volersi bene è contagioso» così ha risposto Monsignor Antonello ad alcuni dei quesiti carichi di curiosità e di vita vissuta posti dai ragazzi.
Per i giovani della nostra Diocesi un invito alla riflessione guidati dalla Parola di Dio, un motivo per essere cristiani nella vita di ogni giorno e lì, nelle relazioni che la affollano, sperimentare l’amore, la ragione del cuore.

Restituire al malato il senso di una intatta dignità
di Stefano Mele.
A pochi mesi dall’approvazione della legge toscana volta a disciplinare il suicidio assistito, anche la Regione sarda il 17 settembre ha varato una legge simile, sulla base di uno schema, proposto dall’Associazione Luca Coscioni, che in altri Consigli regionali è stato rigettato per diversi motivi. È probabile che anche in questo secondo caso la legge verrà impugnata dal Governo dinanzi alla Corte Costituzionale, in quanto riguarda materia la cui competenza sarebbe riservata al Parlamento. In questa sede legislativa, tra l’altro, è in fase di elaborazione un testo di legge che regolamenti l’accesso al suicidio assistito, conservando strettamente i confini in cui la Consulta, con la sentenza 242 del 2019, lo ha dichiarato non punibile, senza revocarne il divieto, previsto dall’art. 580 del codice penale.
La legge sarda prevede che la richiesta dell’interessato – dopo essere passata al vaglio di una commissione medica e del comitato etico territorialmente competente – ottenga una risposta entro 30 giorni. Impressiona la drammatica discrepanza con i lunghissimi tempi di attesa per ottenere una visita specialistica, magari capace di salvare una vita, piuttosto che toglierla! I medici che compongono la commissione chiamata a verificare la presenza dei requisiti per l’accesso al suicidio e quelli che assistono materialmente il malato sono scelti su base volontaria. Ciò non toglie che medici e servizio sanitario cambieranno natura; tra i loro scopi non ci saranno solo la salvaguardia della vita, la cura della salute e l’alleviamento delle sofferenze – nei limiti delle capacità e degli strumenti proporzionati disponibili – ma anche di aiutare a darsi, e forse domani a dare direttamente, la morte.
Durante l’estate appena trascorsa sono stati pubblicizzati alcuni casi di persone che hanno ottenuto l’aiuto richiesto per togliersi la vita. Amareggia registrare l’allargarsi del consenso, l’approvazione e una certa ammirazione per questi gesti, drammatici ed estremi. Preoccupa che vengano ritenute leggi di civiltà, di progresso, di libertà, quelle che prevedono il dare o darsi la morte. Amarezza e preoccupazione sono state espresse anche dalla Conferenza episcopale sarda, la quale ha ribadito «che la vita va sempre difesa, per cui non è accettabile aiutare un malato a morire» e «che la dignità non finisce con la malattia o quando viene meno l’efficienza. Non si tratta di accanimento terapeutico, al quale siamo sempre contrari, ma di non smarrire l’umanità».
Credo di riuscire a comprendere – non meno di altri – la sofferenza di tanti malati, i dolori fisici, la perdita di autonomia e l’ansia di pesare sui propri cari, il senso di inutilità, di indegnità o abbandono, la disperazione che toglie senso e gusto del vivere… Sono convinto però che la pietà, non solo sentimentale ma razionale e concreta, piuttosto che confermare i malati nella loro disistima e nelle loro paure dovrebbe cercare di restituire loro il senso della propria intatta dignità, la convinzione non solo di ottenere cura da parte dei sani, ma di poter dare ancora molto ai propri cari e alla società. Naturalmente questo impegno relazionale e affettivo deve accompagnarsi con quello di alleviare anche i dolori fisici, attraverso la terapia del dolore, che oggi conta su molti strumenti di tipo farmacologico, psicoterapico e chirurgico.
Con questi obiettivi è certamente coerente il piano di potenziamento della rete di cure palliative, approvato sempre di recente dalla Giunta regionale con l’obiettivo ambizioso di raggiungere il 90% dei malati interessati entro il 2028. Aumentare il numero degli hospice, incrementare e formare il personale specializzato, assicurare la cura ambulatoriale e domiciliare, sostenere i caregivers. Questa è la strada giusta, più impegnativa e più onerosa dal punto di vista economico, ma certamente più umana, più benefica, più civile. La vita, senza la quale nessun altro bene, compresa la libertà, può essere goduto, è il bene fondamentale di cui dobbiamo difendere il corrispettivo diritto e che abbiamo il dovere di rispettare sempre.

La pace? Sì, è possibile
di Lucia Capuzzi.
Quando si sono incontrati la prima volta, dodici anni fa, a una fiera turistica, Maoz Inon e Aziz Abu Sarah non hanno pensato che le loro esistenze si sarebbero intrecciate in modo tanto intimo. Ancor meno avrebbero immaginato che a cucirle insieme sarebbe stato un feroce massacro. Il più feroce che abbia colpito gli ebrei dalla Seconda guerra mondiale: la strage perpetrata da Hamas il 7 ottobre 2023. Tra le decine di kibbutz razziate dal gruppo armato quel giorno c’è Nir Am, una comunità nel sud di Israele di 650 abitanti. Gli Inon, Bilha e Yakovi, artista 76enne lei, imprenditore agricolo 78enne lui, erano due di loro. I miliziani li hanno assassinati insieme ad altri 1.200. Quando Maoz ha ricevuto la notizia ha sentito il mondo crollargli addosso. Il figlio non ha lasciato, però, che la rabbia lo avvelenasse. A meno di due settimane dalla tragedia, ha rivolto un appello pubblico a fermare la guerra a Gaza.
Il gesto ha colpito nel profondo Aziz a cui, nel 1990, il conflitto israelo-palestinese aveva strappato il fratello 19enne, Tayseer, arrestato e seviziato dalle autorità di Tel Aviv. Ha, così, recuperato il contatto e gli ha scritto su WhatsApp: «Sono così dispiaciuto per i tuoi genitori. Il mio cuore è spezzato. È terribile, non ho parole. È stata un’azione da vigliacchi. Ti invio tutto il mio sostegno e affetto».
Le parole si sono fatte largo nello spirito di Maoz, aprendo una strada nuova che entrambi ora percorrono insieme. E che, sono convinti, possa condurre i rispettivi popoli alla pace. Di fronte alla loro sofferenza «non si può dire nulla, non si può dire nulla…», ha sussurrato, con voce rotta dall’emozione un commosso Papa Francesco quando li ha visti abbracciarsi il 18 maggio 2023 a Verona nel corso di Arena di Pace. «Non è solo coraggio e testimonianza di volere la pace – ha sottolineato – ma anche un progetto di futuro».
Questo è il significato più profondo di speranza: una possibilità di un domani non schiavo del presente. Maoz e Aziz incarnano, con le rispettive esistenze, il titolo di quest’edizione della Pastorale del Turismo: cercatori di speranza. Condividendo le proprie storie in tutto il mondo. E promuovendo l’educazione alla nonviolenza con l’organizzazione Interact che hanno creato. «Per anni, dopo l’omicidio di mio fratello, ho coltivato il desiderio di vendicarmi. Pensavo non ci fosse altra opzione. È stato studiando ebraico insieme agli immigrati in Israele che ho sentito di poter finalmente scegliere chi essere. E ho deciso di non somigliare agli assassini di Tayseer», ha raccontato Aziz.
«Dopo la morte dei miei genitori ero in pezzi. Una notte ho sognato le vittime del massacro – gli ha fatto eco Maoz –. Dai loro occhi scendevano grosse lacrime che arrivavano fino alla terra, intrisa di sangue. Al cadere, le lacrime pulivano il sangue, facendo comparire un sentiero. Quando mi sono svegliato ho capito: da tutta quella sofferenza, le atrocità perpetrate, l’angoscia inflitta, doveva nascere un nuovo corso». Il termine “sogno” include la radice sanscrita “ap”, le acque primordiali da cui si genera la vita. La stessa che ritroviamo in “speranza”.

Pastorale e carità. Gli interventi 8xmille
di Pier Tomaso Deplano.
Come ogni anno, la Diocesi ha inviato alla CEI il rendiconto sull’uso dei fondi 8xmille, corredato da un’illustrazione dettagliata delle spese.
Si conferma così una rendicontazione necessaria e una risposta rigorosa, grazie alla trasparenza, dei fondi ottenuti nel 2024.
Il rendiconto si suddivide in voci precise che consentono di comprendere le spese sostenute. Accanto alla quota proveniente dall’8xmille per il culto e la pastorale, figurano (nel quadro presentato) anche le entrate e le successive uscite derivanti da finanziamenti regionali, comunali e talvolta parrocchiali, per i singoli progetti. Un quadro articolato che riflette la complessità delle attività e l’impegno su molti fronti.
Il contributo per il culto e la pastorale del 2024 è stato utilizzato in buona parte per rispondere alle necessità della manutenzione degli edifici di culto (chiese, locali, case parrocchiali). Si tratta di lavori di conservazione e miglioramento delle strutture, compresi gli oratori. Non è mancata l’attenzione alla formazione dei sacerdoti, dei diaconi e dei laici, sia con iniziative periodiche che in altre più diradate. Curia e uffici diocesani hanno potuto usufruire per i loro servizi dei contributi necessari, con le finalità tipiche della pastorale di una Chiesa in missione: iniziative catechistiche-teologiche-pastorali, promozione della cultura religiosa, supporto ai mezzi di comunicazione sociale.
Il contributo per la carità, anche quest’anno, si è tramutato con interventi promossi dalle parrocchie o attraverso la Caritas diocesana: sostegno economico alle famiglie e alle persone in difficoltà, progetti specifici con obiettivi di settore, scelta di attenzioni e di sensibilità nel territorio, anche a favore di associazioni o gruppi di volontariato.
Le strutture diocesane esistenti, sia a Lanusei che a Tortolì, hanno lavorato per questi scopi, incrementando il programma di attività, anche grazie alle collaborazioni avviate, tra le quali anche quella con la cooperativa Amos. Di particolare importanza, inoltre, le risorse dedicate al Museo, all’Archivio e alla Biblioteca.
In sintesi. Il rendiconto annuale è uno strumento di condivisione e corresponsabilità attraverso la quale la Diocesi di Lanusei conferma il proprio impegno nella gestione delle risorse provenienti dall’8xmille, contribuendo così ai fini preposti e generando nel territorio una presenza significativa di Chiesa. Il rendiconto si accompagna al bilancio più ampio della Diocesi, generato da altre entrate e quindi da uscite più articolate.

Perché la Costituzione non resti lettera morta
di Giusy Mameli.
Ogni anno il mese di maggio è dedicato alla memoria storica, complici le ricorrenze drammatiche delle stragi di mafia.
Grazie al presidio di legalità – come viene spesso definito il Tribunale –, anche in Ogliastra le iniziative si sono moltiplicate coinvolgendo il Foro locale. Il Presidente in carica, l’avvocato Vito Cofano, è intervenuto con altri colleghi insieme a Paola Del Monte, Procuratrice della Repubblica e alla sua sostituta, Giuseppina Morra, in un progetto di legalità, una simulazione del processo nelle classi quinte della Scuola primaria Centrale di Tortolì.
È importante che fin da bambini ci si avvicini alle Istituzioni per maturare una coscienza civica e percepire lo Stato più vicino ai cittadini. Negli anni passati il Consiglio dell’Ordine degli avvocati – in particolare sotto la presidenza dell’avvocato Gianni Carrus, con la collaborazione dei magistrati, delle forze di polizia del territorio, delle Amministrazioni locali e delle Istituzioni scolastiche – ha promosso azioni volte a sensibilizzare i giovani e innovare la formazione (comprese l’alternanza scuola-lavoro nei Licei di Lanusei e di Tortolì). Sono progetti consolidati e altamente qualificanti, comprese le testimonianze di persone a vario titolo protagoniste degli eventi storici più importanti.
Non dimentichiamo le mobilitazioni popolari degli anni scorsi a difesa dei presidi sanitari (l’Ospedale) e giudiziari (il Tribunale e la Casa Circondariale) che ciclicamente siamo chiamati a difendere da notizie di soppressione o depotenziamento.
Intanto, è di questi giorni la notizia che Massimiliano Tuveri – chirurgo di chiara fama – non opererà all’ospedale Brotzu di Cagliari, ma ripartirà da Lanusei, con buona pace dei pochi detrattori e della contraddizioni burocratiche-sanitarie sarde (per usare un eufemismo). Possibile che la legalità venga posta in secondo piano anche nel sistema pubblico? Avremo presto possibilità di riparlarne ma, al di là delle singole vicende, dobbiamo chiederci quale etica sovrintende a certe incomprensibili e illogiche, per non dire illegittime, decisioni.
Non possono avvallarsi prassi contabili dei diritti e dei bisogni delle popolazioni: una pericolosa deriva utilitaristica priva di etica solidaristica. Per fortuna la Chiesa ha sopperito a talune carenze dello Stato (vicina ai cittadini anche nelle battaglie sociali irrinunciabili, per il lavoro, la salute, l’istruzione, la giustizia), fornendo risposte in tempi più brevi anche con soluzioni momentanee ma importanti (ad esempio l’aiuto economico ai cassintegrati della Cartiera di Arbatax o la rivisitazione del sistema Caritas, che sta sostenendo chi si trova in situazioni, anche momentanee, di indigenza). Cercare di mantenere alta l’attenzione sui diritti legittimi delle cosiddette periferie (che poi periferie non sono perché paghiamo le tasse e pertanto abbiamo – in teoria – gli stessi diritti del resto d’Italia), promuovere legalità, equità sociale a prescindere dai numeri: fa sì che la Costituzione non resti lettera morta.
La cultura della legalità non fa parte integrante del nostro vivere quotidiano, dati i fatti di cronaca sempre attuali di varia criminalità. Si tratta di tematiche sviscerate spesso nell’ambito degli incontri della Pastorale del Turismo, che ogni anno non manca di richiamare l’attenzione. Dobbiamo fare in modo che l’emozione non si fermi alle commemorazioni e ai convegni, ma si trasformi in coscienza illuminata e partecipazione consapevole.

Pellegrini di speranza a Roma
di Antonio Carta.
Dal 15 al 20 marzo ha avuto luogo il pellegrinaggio interdiocesano a Roma guidato dal vescovo Antonello, che ha riunito i pellegrini delle due diocesi di Lanusei e Nuoro
C’è un momento preciso in cui il pellegrinaggio inizia davvero. Non è quando si sale sull’autobus, né quando si arriva a destinazione. Il vero inizio avviene quando, tra una preghiera e una battuta, tra un sorriso e un sospiro di fatica, ciascuno di noi si rende conto che non sta percorrendo la strada da solo. Ottantaquattro pellegrini, due diocesi, un solo vescovo e un unico cammino: un pellegrinaggio di speranza, in questo Anno Santo, tra i luoghi più significativi della Città Eterna.
Roma, con il suo fascino intramontabile, non smette mai di sorprendere. Quando la cupola di San Pietro si affaccia tra i palazzi, il brusio del gruppo si riempie di stupore. C’è chi scatta una foto, chi si ferma a prendere un attimo di respiro, mentre il vescovo Antonello incalza il passo per non perdere nemmeno un appuntamento. Per gustare realmente un pellegrinaggio è sempre necessario rinnovare la consapevolezza che non si sta vivendo un semplice viaggio, ma una vera occasione di incontro, con Dio, con gli altri e con se stessi.
Camminare per le strade di Roma con qualcuno accanto è sempre un’esperienza piacevole e confortante. Si sorride, si raccontano storie, i passi si sincronizzano. Ma durante un pellegrinaggio, lo sappiamo bene, a volte bisogna rallentare, altre volte accelerare, altre ancora stringersi l’un l’altro per riuscire a salire tutti insieme sul bus 64.
Durante la visita alle Grotte Vaticane, alcuni di noi si sono lasciati affascinare dalla straordinaria bellezza di quei luoghi, così ricchi di storia e di fede, perdendo temporaneamente l’orientamento, salvo poi riunirsi rapidamente. Mons. Tiziano Ghirelli, canonico di San Pietro, ci ha guidati in un percorso affascinante tra arte, simbolismo e spiritualità. Paola, nostra vivace e instancabile guida di origini ogliastrine, ci ha condotti invece alla scoperta di alcune delle basiliche più emblematiche di Roma, come Santa Maria Maggiore e San Giovanni in Laterano, senza dimenticare la Basilica di Santa Croce, e per alcuni, l’emozionante esperienza dei gradini della Scala Santa. Un monaco benedettino, anch’egli di origini sarde, ci ha invece accompagnato alla scoperta della Basilica di San Paolo, per poi avventurarci successivamente nelle misteriose catacombe di San Sebastiano. Nell’ultimo giorno, la testimonianza di Giustino ha dato un tocco finale di profondità e riflessione al nostro pellegrinaggio.
Tuttavia, tra tutti i momenti vissuti, quelli che resteranno nel cuore di ciascuno sono sicuramente i passaggi attraverso le Porte Sante. Alcuni sono stati vissuti in modo comunitario, altri in maniera più personale e intima. Ogni varco, ogni porta, ha rappresentato un atto di fede, di accoglienza, di perdono. E proprio lì, nel passaggio da un mondo a un altro, si è rivelato il cuore del nostro pellegrinaggio: il cammino fatto insieme, sulla strada di un Dio Misericordia, che si è fatto uomo per camminare tra noi.
Il vescovo Antonello ci ha sempre guidato con parole ricche di saggezza, illuminando il nostro cammino con sguardo profetico e lungimirante. Ogni sua riflessione, ogni sua lettura,ci ha fatto comprendere che il vero significato del pellegrinaggio non risiede solo nei luoghi che abbiamo visitato, ma nel modo in cui li abbiamo realmente vissuti.
Il viaggio di ritorno ha ritmo diverso. Meno parole, più pensieri. Le esperienze forti hanno bisogno di tempo per essere comprese. Forse nessuno di noi torna a casa con risposte definitive, ma una cosa è certa: il pellegrinaggio non è finito. Siamo chiamati a essere pellegrini di speranza ogni giorno. L’ulteriore Porta Santa da attraversare sarà quella della nostra quotidianità, in cui ciascuno di noi può continuare a vivere e a testimoniare la fede rinvigorita nel cuore durante il cammino a Roma.

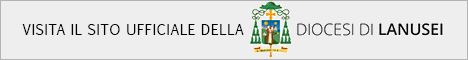







.png)